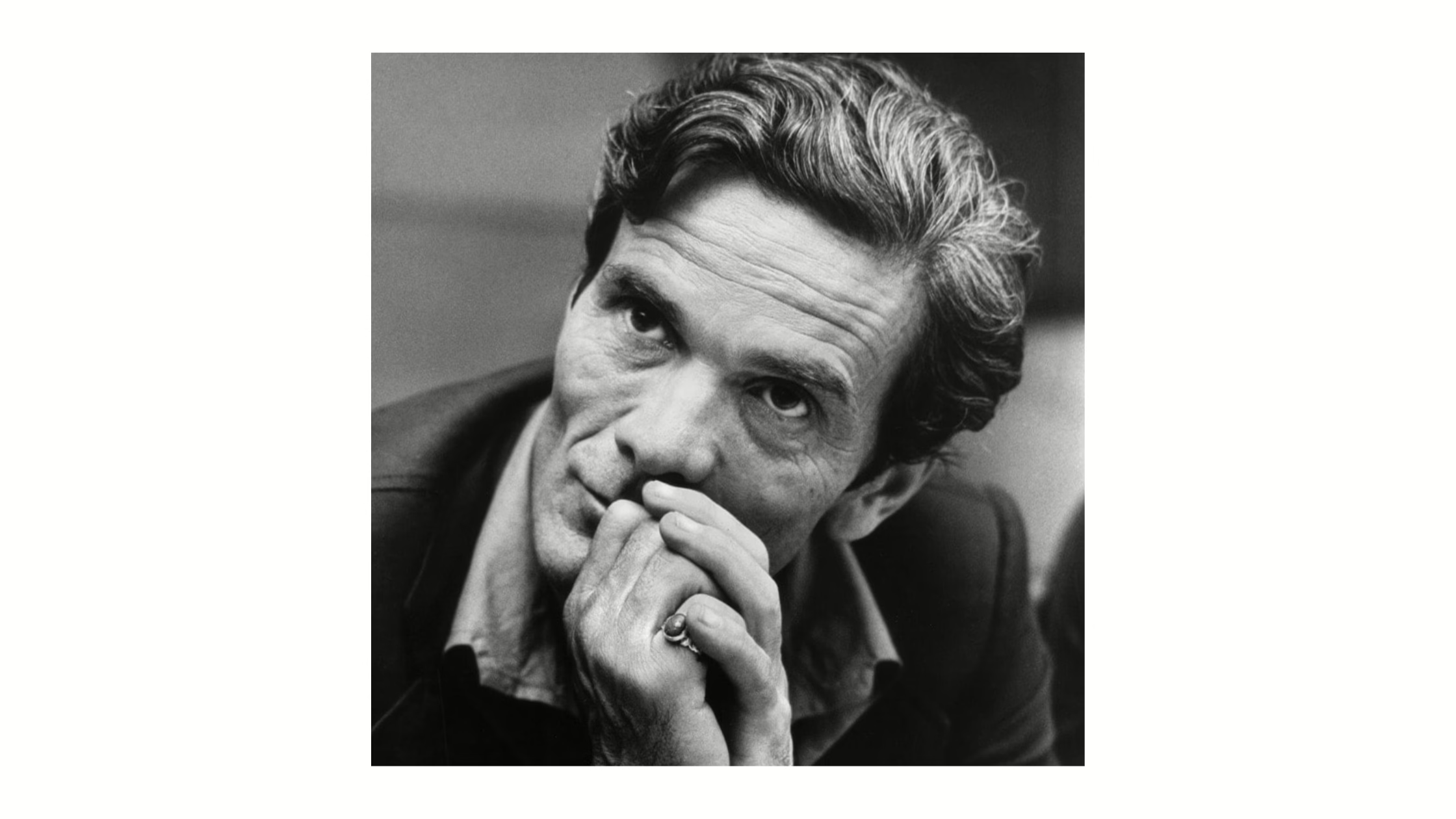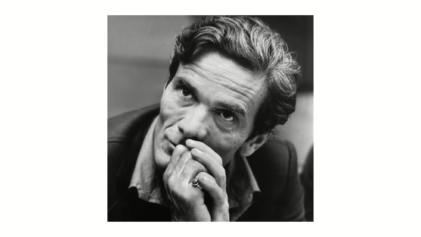La selezione di un testo pasoliniano per la prova di italiano dell’Esame di Stato 2025 rappresenta un riconoscimento significativo della centralità dell’opera dell’intellettuale friulano nel panorama letterario novecentesco. L’Appendice I a «Dal diario» (1943-1944), scelta come traccia per la tipologia A, offre agli studenti un’occasione preziosa per confrontarsi con la complessità poetica di un autore che ha attraversato e interpretato le trasformazioni culturali e sociali dell’Italia contemporanea. Questa lirica giovanile, composta durante gli anni della formazione universitaria bolognese, anticipa molti dei temi che caratterizzeranno l’intera produzione pasoliniana: il rapporto problematico con il tempo, la tensione tra innocenza e consapevolezza, la ricerca di un’autenticità sempre sfuggente.
Contestualizzazione storico-letteraria
Il componimento si inserisce nel primo nucleo della produzione poetica pasoliniana, quello delle raccolte giovanili che precedono la celebre trilogia friulana. Scritto tra il 1943 e il 1944, il testo appartiene a un periodo di formazione cruciale per l’autore, caratterizzato dalla frequentazione dell’università di Bologna, dai primi esperimenti letterari e dall’elaborazione di una propria identità intellettuale. In questo contesto, la poesia si configura come un laboratorio di sperimentazione linguistica e tematica, dove confluiscono le suggestioni dell’ermetismo – movimento dominante nella poesia italiana degli anni Trenta e Quaranta – e una più personale ricerca di espressione lirica.
La scelta di pubblicare questo testo nell’edizione critica curata da Walter Siti testimonia l’importanza attribuita dalla critica contemporanea anche alla produzione giovanile pasoliniana, spesso considerata preparatoria rispetto ai capolavori della maturità. Tuttavia, una lettura attenta rivela come già in questi primi esperimenti siano presenti i nuclei tematici e stilistici che caratterizzeranno l’intera opera dell’autore.
Analisi strutturale e metrica
Dal punto di vista formale, la lirica presenta una struttura apparentemente libera, ma organizzata secondo una logica interna rigorosa. I diciannove versi si articolano in un’unica strofa, seguendo un andamento discorsivo che mima il flusso della riflessione interiore. La metrica, pur non aderendo a schemi tradizionali, mantiene una musicalità evidente, ottenuta attraverso l’alternanza di versi lunghi e brevi, l’uso sapiente degli enjambements e la ricorrenza di assonanze e consonanze.
La scansione ritmica privilegia l’endecasillabo e il settenario, metri della tradizione lirica italiana, ma li inserisce in una tessitura versificatoria più libera, che riflette l’influenza dell’ermetismo e della poesia europea contemporanea. Particolarmente significativo è l’uso dell’enjambement, che spezza le unità sintattiche creando effetti di sospensione e continuità: “non muta / il silenzio”, “è stinta / tutta quella luce”, “come / inesistente”. Questa tecnica contribuisce a creare un ritmo ondulatorio che rispecchia l’alternarsi di memoria e presente, di disillusione e speranza.
Nuclei tematici fondamentali
Il Tempo e la Memoria
Il tema centrale del componimento è costituito dalla riflessione sul tempo e sul rapporto tra passato e presente. Il poeta si confronta con la propria crescita esistenziale attraverso un processo di sovrapposizione temporale: “col volto di ragazzo, e adolescente, / e ora uomo”. Questa stratificazione dell’identità nel tempo rivela una concezione non lineare della temporalità, dove i diversi momenti dell’esistenza coesistono in una simultaneità problematica.
La dimensione memoriale si configura come elemento di continuità ma anche di straniamento. Il “medesimo mondo” che “annotta da millenni” rappresenta l’immutabilità del paesaggio naturale, contrapposta alla mutevolezza dell’interiorità umana. Questa antitesi genera una tensione dialettica che attraversa l’intero testo, manifestandosi nell’opposizione tra permanenza e cambiamento, eternità e transitorietà.
La Disillusione dell’Età Adulta
Il passaggio dall’adolescenza alla maturità viene rappresentato come perdita di una capacità di illusione che caratterizzava l’età giovanile. La metafora della luce che “riarde la campagna” e che si è “stinta” dopo “poche notti” simboleggia l’esaurimento di quella facoltà visionaria che permetteva di percepire il mondo come intrinsecamente significativo. Le “mille lune” che “non son bastate a illudermi di un tempo / che veramente fosse mio” esprimono la consapevolezza della perdita di un rapporto autentico con la dimensione temporale.
Questa tematica anticipa la riflessione pasoliniana sulla perdita dell’innocenza, che diventerà centrale nella produzione successiva, assumendo valenze politiche e antropologiche più ampie. Già in questa lirica giovanile, tuttavia, emerge la nostalgia per una condizione di autenticità perduta, che si configura come cifra caratteristica dell’intera opera dell’autore.
Il Paesaggio come Correlativo Oggettivo
Il paesaggio naturale – la stanza, i muri bianchi, le acque, la campagna, la luna – non costituisce un semplice sfondo descrittivo, ma funziona come correlativo oggettivo degli stati d’animo del soggetto lirico. La tecnica, di derivazione simbolista ed ermetica, permette di oggettivare l’interiorità attraverso la proiezione sui dati fenomenici della realtà esterna.
La luna, in particolare, assume un valore simbolico complesso: prima “breve arco” nel cielo, poi “discesa, e ferma, come / inesistente nella stanca luce”, infine apparentemente rinnovata nell’illusione finale. Questa trasformazione dell’immagine lunare rispecchia il movimento emotivo del poeta, dal senso di vuoto iniziale alla momentanea rinascita della speranza.
Analisi linguistica e stilistica
Il lessico del componimento rivela una stratificazione di registri linguistici che testimonia la formazione culturale dell’autore e le influenze subite dalla poesia contemporanea. Accanto a termini di uso comune (“stanza”, “volto”, “mondo”), compaiono vocaboli di registro più elevato (“riarde”, “millennii”) e costruzioni sintattiche di sapore aulico (“Volgo il capo”).
Particolarmente significativa è la scelta di alcuni verbi che conferiscono dinamismo alla rappresentazione: “ritrovo”, “muta”, “annotta”, “riarde”, “rispecchia”. Questi termini creano un movimento continuo che controbilancia la staticità apparente della situazione descritta, suggerendo un’inquietudine sotterranea che percorre l’intero testo.
L’uso degli aggettivi rivela una predilezione per epiteti che suggeriscono condizioni esistenziali: “stanco”, “scuro”, “sereno”, “esausto”, “perfetto”, “quieti”, “antico”. Questa aggettivazione qualificativa contribuisce a creare un’atmosfera di sospensione contemplativa, caratteristica della poesia ermetica.
La Dimensione Sonora e il Finale Epifanico
L’architettura sonora del componimento culmina nell’immagine finale dei grilli che “cantare quieti […] il canto antico”. Questa conclusione introduce una dimensione uditiva che rompe il silenzio dominante nel resto del testo, creando un effetto di improvvisa rivelazione. Il “canto antico” dei grilli rappresenta la persistenza di una naturalità primordiale che sopravvive alla disillusione moderna, offrendo una possibile via di riconciliazione con l’autenticità perduta.
La scelta dell’infinito “cantare” invece del presente “cantano” conferisce all’azione una dimensione atemporale, sottraendola alla contingenza del momento per proiettarla in una dimensione di eternità. Questo artificio stilistico intensifica l’effetto epifanico della conclusione, suggerendo una possibile trascendenza della condizione di alienazione descritta nel resto del testo.
Confronti intertestuali e influenze
L’Appendice I a «Dal diario» rivela l’influenza della tradizione lirica italiana, dal Leopardi dei Canti alla poesia ermetica contemporanea. Il tema della luna rimanda inevitabilmente alla tradizione romantica, ma viene qui rielaborato secondo una sensibilità novecentesca che privilegia la frammentazione e l’interiorizzazione dell’esperienza.
Più specificamente, si possono individuare echi dell’ermetismo ungarettiano nella tecnica dell’analogia e nella costruzione per frammenti lirici, mentre la dimensione paesaggistica ricorda certa poesia di Montale, particolarmente quella degli Ossi di seppia. Tuttavia, Pasolini elabora questi influssi secondo una personalissima sintesi, che anticipa i successivi sviluppi della sua poetica.
Leggi anche La rivoluzione poetica di Montale con Ossi di seppia
Significato nell’opera pasoliniana
Questa lirica giovanile prefigura molti dei temi che caratterizzeranno l’intera produzione pasoliniana: il rapporto problematico con il tempo storico, la nostalgia per un’autenticità perduta, la tensione tra memoria e presente. In particolare, la contrapposizione tra “ieri” e “oggi”, tra innocenza e consapevolezza, anticipa la riflessione antropologica che Pasolini svilupperà negli anni della maturità, quando questi temi assumeranno valenze politiche e sociali più ampie.
La poesia testimonia inoltre la ricerca di una forma espressiva capace di rendere la complessità dell’esperienza moderna, oscillante tra frammentazione e totalità, tra particolare e universale. In questo senso, il testo si configura come un importante documento della formazione artistica pasoliniana e, più in generale, della poesia italiana del secondo Novecento.
L’Appendice I a «Dal diario» rappresenta un momento significativo nella produzione giovanile di Pasolini, testimoniando la precoce maturità artistica dell’autore e la sua capacità di trasformare l’esperienza biografica in materia poetica universale. La lirica anticipa molti dei temi centrali dell’opera pasoliniana, offrendo al contempo un esempio paradigmatico della ricerca formale che caratterizza la poesia italiana degli anni Quaranta.
La scelta di questo testo per l’Esame di Stato sottolinea l’importanza di Pasolini nel canone letterario contemporaneo e offre agli studenti un’occasione preziosa per confrontarsi con la complessità e la ricchezza della tradizione poetica italiana. L’analisi di questa lirica permette infatti di cogliere i nodi fondamentali della poetica pasoliniana e, più in generale, le caratteristiche della lirica novecentesca italiana, nella sua continua tensione tra tradizione e innovazione, tra memoria del passato e interrogazione del presente.