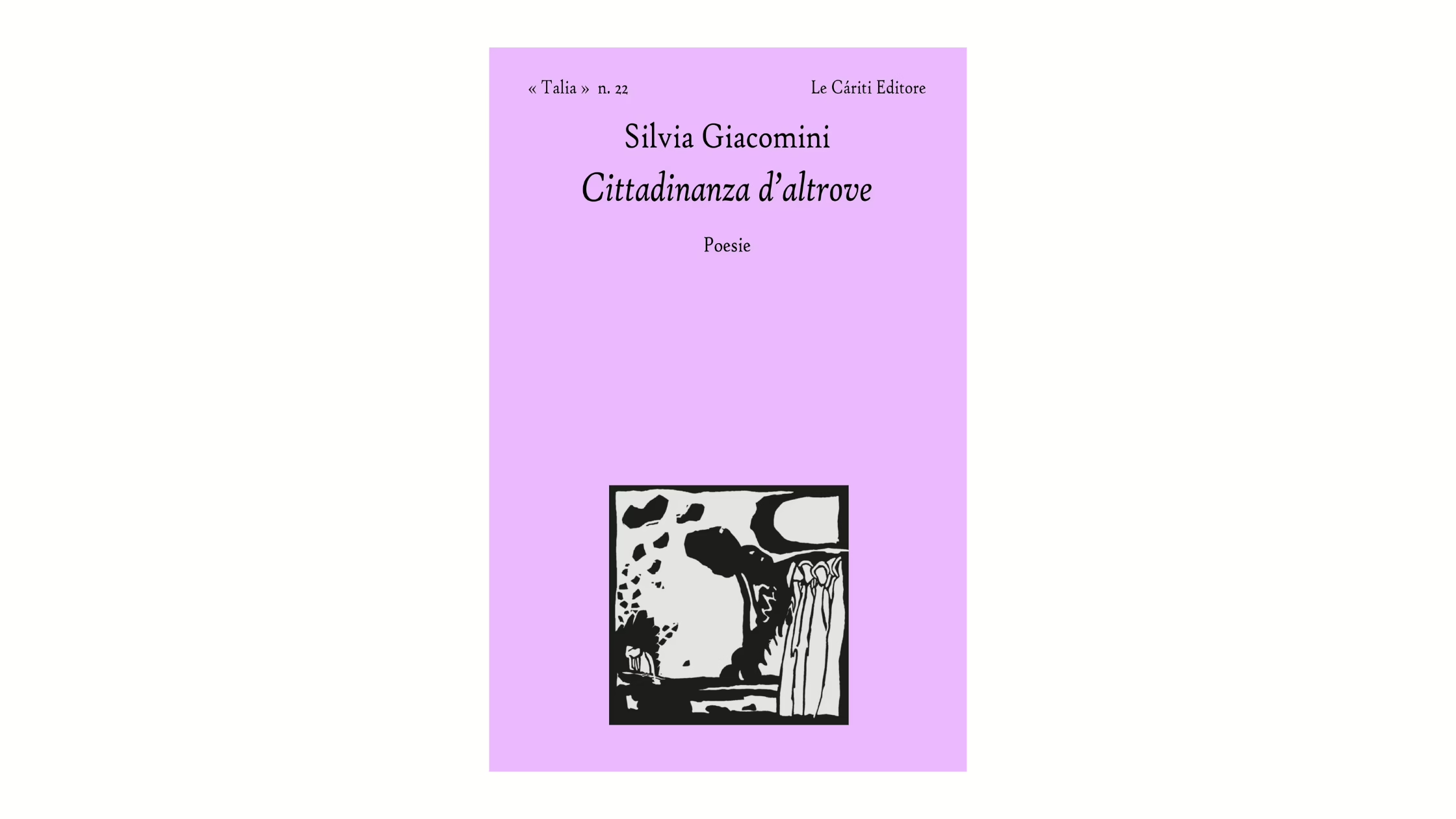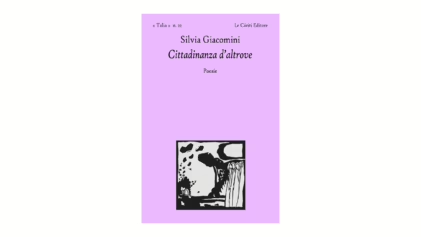La raccolta poetica Cittadinanza d’altrove di Silvia Giacomini, pubblicata da Le Cáriti Editore nel 2025, si configura come un’opera di straordinaria complessità ermeneutica che richiede un approccio critico multidisciplinare. Il volume, strutturato in tre sezioni principali precedute da un’epigrafe programmatica tratta da Cristina Campo, presenta una cifra stilistica e tematica che si colloca nell’alveo della tradizione poetica italiana contemporanea più consapevole delle proprie matrici filosofico-esistenziali.
L’organizzazione tripartita del volume rivela una precisa strategia compositiva che muove dall’indagine fenomenologica dell’alterità esistenziale (Il pianoforte anomalo) verso la dimensione memoriale e affettiva del lutto (Avanzare di ritorno) per approdare infine alla dissoluzione metafisica dell’esperienza temporale (Morte del tempo). Questa progressione non è meramente cronologica ma assume i contorni di un percorso iniziatico che dalla marginalità sociale conduce verso una forma di trascendenza immanente.
La scelta dell’epigrafe campiana non rappresenta un mero omaggio letterario ma costituisce la chiave ermeneutica dell’intera operazione poetica. Il riferimento alla “luce d’infanzia e di fiaba” come criterio di riconoscimento degli “eventi essenziali” stabilisce fin dall’incipit il registro gnoseologico dell’opera, fondato sulla tensione dialettica tra esperienza fenomenica e dimensione visionaria.
La prima sezione: fenomenologia dell’esclusione
La sezione inaugurale, dominata dalla figura del “cigno sgraziato”, sviluppa una complessa meditazione sull’esperienza della neurodivergenza e dell’ipersensibilità percettiva. Il poemetto omonimo, articolato in nove movimenti, presenta una struttura che richiama le forme musicali del Novecento, con variazioni tematiche che approfondiscono progressivamente il nucleo semantico dell’esclusione sociale.
L’immagine del cigno che “aveva osato abbandonare il lago” e viene “bersagliato di sassi” da “una banda di bambini vuoti” costituisce una metafora di particolare efficacia della condizione dell’individuo neurodivergente nella società contemporanea. La “torre di pietra” che cresce “attorno rapida / per tutta la lunghezza del collo” rappresenta plasticamente il processo di isolamento e stigmatizzazione che caratterizza l’esperienza dell’alterità neurologica.
La poetica della Giacomini rivela qui una profonda consapevolezza delle dinamiche di marginalizzazione sociale, sviluppando un discorso che trascende la dimensione meramente autobiografica per assumere valenza antropologica. Il verso “Nessuna ferita / ma una torre di pietra” sintetizza con straordinaria pregnanza semantica la violenza simbolica che si esercita sui soggetti non conformi alle norme neurotipiche.
Il linguaggio della differenza: Divergenti luci
La seconda parte della prima sezione, intitolata Divergenti luci, presenta una serie di componimenti che adottano una strategia enunciativa polifonica, dando voce a soggetti “autistici, PAS (altamente sensibili), variamente difformi”. Questa scelta compositiva rivela una precisa intenzione documentaria che conferisce all’opera una dimensione testimoniale di particolare rilevanza sociologica.
Il discorso poetico si articola attraverso una fenomenologia dell’esperienza percettiva atipica, restituendo la complessità del vissuto neurodivergente attraverso un linguaggio che mima le modalità cognitive specifiche di questi soggetti. Versi come “Parlare non è darsi, / è mascherare il caos” o “Le opinioni tornano polvere / alla prima scossa d’ascolto” restituiscono con precisione scientifica le difficoltà comunicative che caratterizzano molte forme di neurodivergenza.
La poeta dimostra una particolare sensibilità nell’evitare ogni forma di patologizzazione del discorso, optando invece per una rappresentazione che valorizza la specificità percettiva come forma di conoscenza alternativa. Il verso “Sono tachicardia e rossore / sono vergogna di esistere / sono un milione di abortite / possibilità di me” sintetizza con potenza lirica la frammentazione identitaria che caratterizza l’esperienza della differenza neurologica.
La dimensione temporale e la memoria: Avanzare di ritorno
La seconda sezione del volume sviluppa una complessa meditazione sul tema della memoria e del lutto, assumendo come riferimento teorico l’espressione campiana dell'”avanzare di ritorno”. Questa sezione si caratterizza per un registro emotivo di particolare intensità, dove la dimensione privata del dolore si trasforma in riflessione universale sulla condizione umana.
Il poemetto Una luce d’oro piena di tempo presenta una struttura dialogica che evoca la presenza di un interlocutore assente, probabilmente identificabile con l’amico Matteo a cui è dedicata l’intera raccolta. La citazione dai diari Facebook di Matteo M. Vecchio che precede il componimento conferisce al testo una dimensione meta-letteraria che problematizza il rapporto tra esperienza vissuta e rappresentazione poetica.
L’elaborazione del lutto assume qui forme di particolare complessità psicologica, dove il dolore per la perdita si trasforma in interrogazione metafisica sulla persistenza dell’essere oltre la morte fisica. Versi come “Non esistono addii. / Solo attese che durano una vita” rivelano una concezione temporale non lineare che rifiuta la definitività della separazione.
La fenomenologia del dolore
La poetica del lutto sviluppata dalla Giacomini presenta caratteristiche di notevole originalità nel panorama della lirica italiana contemporanea. L’esperienza della perdita non viene elaborata attraverso i tradizionali moduli consolatori della tradizione letteraria ma assume le forme di una ricerca fenomenologica che indaga le modalità concrete del soffrire.
Il componimento Sulla terra con un piede solo sviluppa una metafisica dell’incompletezza che definisce la condizione post-luttuosa come forma di esistenza liminale: “Sulla terra si sta con un piede solo, / l’altro poggia in un altrove”. Questa immagine sintetizza con efficacia la condizione di chi sopravvive alla perdita degli affetti, configurandosi come soggetto ibrido tra dimensione terrestre e trascendente.
La sezione presenta inoltre una riflessione di particolare profondità sul rapporto tra memoria e oblio, sviluppando un discorso che problematizza la tradizionale opposizione tra ricordo e dimenticanza. Il verso “Ho così paura di dimenticare – / dimenticare è perdere tutto, / irrimediabile non essere” rivela un’angoscia ontologica che trascende la dimensione meramente psicologica per assumere carattere filosofico.
La dissoluzione del soggetto: Morte del tempo
La terza e ultima sezione del volume presenta la dissoluzione progressiva dell’io poetico nella dimensione dell’assoluto, sviluppando una mistica immanente che richiama le tradizioni mistiche cristiane e orientali. Il titolo stesso della sezione evoca la sospensione della temporalità lineare caratteristica dell’esperienza mistica.
La prima parte, Spoliazioni, sviluppa una fenomenologia della perdita dell’identità personale attraverso immagini di particolare potenza visionaria. Il verso “Sono la corda di un tiro alla fune / lasciata cadere nella sabbia” inaugura una serie di metafore dell’abbandono che conducono verso la dissoluzione dell’ego.
La poetica della spoliazione presenta qui caratteristiche che richiamano le tradizioni mistiche medievali, in particolare la mistica renana, dove il processo di “Entwerden” (divenire niente) costituisce la condizione necessaria per l’unione con l’assoluto. Tuttavia, la Giacomini sviluppa questa tradizione in chiave contemporanea, evitando ogni forma di fuga dal mondo per mantenere l’ancoraggio alla concretezza dell’esperienza.
Il linguaggio della trascendenza
La sezione Soglie quasi terrestri, quasi stellari presenta la fase più propriamente mistica del percorso poetico, dove l’esperienza dell’assoluto viene colta nella sua ambiguità costitutiva tra immanenza e trascendenza. L’ossimoro del titolo (“quasi terrestri, quasi stellari”) sintetizza questa tensione dialettica che caratterizza l’esperienza del sacro nella modernità.
Il discorso poetico assume qui caratteristiche di particolare rarefazione linguistica, dove la parola tende verso il silenzio nella consapevolezza dell’inadeguatezza del linguaggio di fronte all’esperienza dell’infinito. Versi come “Dire non dice, / dire offenderebbe la parola increata” rivelano una concezione negativa della teologia che ha radici nella tradizione mistica cristiana.
L’ultima parte, Morte del tempo, presenta la dissoluzione finale dell’esperienza temporale nell’eternità dell’istante mistico. La descrizione di questa esperienza assume forme di particolare complessità linguistica, dove la sintassi si frammenta per restituire la dimensione estatica del vissuto: “Abbacinante morte del tempo / saperla dire non basterebbe a possederla / a ricrearla / nei giorni di secca opacità”.
Dal punto di vista formale, la raccolta presenta una versificazione libera che mantiene tuttavia un rigoroso controllo ritmico. La Giacomini dimostra una particolare sensibilità per gli effetti fonici del linguaggio, sviluppando una prosodia che alterna momenti di particolare densità semantica a passaggi di maggiore distensione melodica.
L’uso della punteggiatura rivela una strategia compositiva precisa, dove la frammentazione sintattica mima le modalità cognitive specifiche dei soggetti rappresentati. In particolare, nella sezione Divergenti luci, l’assenza di segni di interpunzione o la loro distribuzione irregolare restituisce efficacemente l’esperienza percettiva frammentata caratteristica della neurodivergenza.
Il lessico presenta una notevole ricchezza semantica che attinge a registri diversi, dalla terminologia scientifica al linguaggio mistico, dalla dimensione colloquiale a quella aulica. Questa pluralità linguistica riflette la complessità dell’esperienza rappresentata, evitando ogni forma di riduzionismo stilistico.
Cittadinanza d’altrove si configura come un’opera di particolare rilevanza nel panorama della poesia italiana contemporanea per la capacità di coniugare rigore formale e autenticità esistenziale. L’autrice riesce a sviluppare un discorso poetico che trascende la dimensione meramente autobiografica per assumere valenza antropologica, offrendo una rappresentazione della condizione neurodivergente che evita ogni forma di vittimismo per valorizzare invece la specificità percettiva come forma di conoscenza alternativa.
La struttura tripartita del volume rivela una precisa strategia compositiva che conduce dal particolare all’universale, dalla marginalità sociale alla dimensione metafisica, realizzando una sintesi tra testimonianza e visione che conferisce all’opera una particolare densità semantica.
Dal punto di vista linguistico, la raccolta presenta caratteristiche di notevole originalità, sviluppando una prosodia che mima efficacemente le modalità cognitive specifiche dei soggetti rappresentati senza cadere nel mimetismo superficiale. La capacità di restituire l’esperienza della differenza neurologica attraverso un linguaggio poetico di particolare raffinatezza costituisce uno dei principali meriti dell’opera.
L’inserimento dell’opera nel contesto della tradizione poetica italiana contemporanea rivela influenze molteplici che vanno dalla lezione campiana alla tradizione mistica cristiana, dalla fenomenologia filosofica alla psicologia cognitiva contemporanea. Questa capacità di sintesi tra tradizione e innovazione conferisce alla raccolta una particolare rilevanza nel panorama letterario attuale.
In conclusione, Cittadinanza d’altrove rappresenta un contributo significativo alla comprensione poetica della condizione umana nella contemporaneità, offrendo una rappresentazione della differenza neurologica che supera gli stereotipi correnti per approdare a una visione più complessa e articolata dell’esperienza neurodivergente. La capacità di trasformare la marginalità in risorsa conoscitiva costituisce il principale merito dell’opera, destinata a segnare – per tali aspetti – un punto di riferimento nella produzione poetica del XXI secolo.
L’AUTRICE
Silvia Giacomini, nata a Busto Arsizio, ha pubblicato due raccolte di racconti, Pozzanghere e bagliori e La metamorfosi delle cose, Progetto Cultura, 2011 e 2015, e le raccolte di poesie La sirena discorde, Edizione Ape, 2012, Il sangue del cielo, Italic Pequod, 2014, La tentazione di essere vento, La vita felice, 2014, e Mal Bianco, Ladolfi, 2019. Attrice di teatro, ha realizzato spettacoli di argomento astronomico e condotto laboratori di drammaterapia nell’ambito del disagio psichico. Ha tenuto mostre personali di incisioni.